Editoriale
- 20 mag 2021
- Tempo di lettura: 2 min
La presunta dittatura del politically correct Se avessi un euro per ogni volta che ho sentitodire “Ormai non si può dire più niente” avrei un gruzzoletto indubbiamente consistente in banca. È decisamente il tormentone del momento, e proprio come tutte le hit genialmente prodotte, questa narrativa “vende” sempre di più. La convinzione che la gente sia sempre più limitata nel parlare dilaga imperterrita in questi giorni, si urla alla mancata libertà di parola ormai da ogni angolo. E la colpa sembra essere di questa mostruosa e restrittiva presunta dittatura del politically correct, ovviamente questa nuova estetica dei giovani progressisti wannabe. Parliamoci chiaro, la semplice realtà è che non vi è alcuna censura o mancata libertà di parola, ci stiamo semplicemente evolvendo come società, o almeno ci stiamo provando. Le legittime pretese del più basilare rispetto non sono niente di nuovo, proprio quelle che sembrano apparentemente così restrittive e censuranti, ci sono sempre state. Semplicemente le voci che la società si è rifiutata di ascoltare per anni hanno finalmente più mezzi di denuncia, prime tra tutte le piattaforme social. Subire una correzione non risulta mai piacevole e credo sia nella natura umana richiedere del tempo per metabolizzarla ed integrare un conseguente e appropriato cambiamento nel proprio atteggiamento. Spesso quando si riceve un call-out riguardo qualcosa di offensivo che si è detto, la prima reazione è mettersi sulla difensiva e assumere l’atteggiamento deresponsabilizzante del “la colpa è tua, persona offesa”. Reagire così porta decisamente a pochi progressi e bisogna accettare che le parole abbiano un impatto forte. Il primo passo verso un concreto cambiamento è invece capire la gravità delle proprie parole e l’immenso significato disumanizzante che spesso queste parole che ci vengono chieste di non dire portano con loro. Mi preme inoltre precisare che le intenzioni non sono tutto, lungi dall’esserlo, per quanto infatti possano sembrare rilevanti, in contesti discriminatori sono decisamente l’opposto. Dire che non si intendeva quella parola in tutta la sua gravità, ma solamente scherzosamente, non sortisce risultato alcuno, un coltello non diventa un cacciavite solo perché lo si desidera. Le parole, in particolare modo gli slurs, comportano delle conseguenze dalle quali derivano giustamente delle responsabilità, a prescindere dalle intenzioni. Questa non vuole essere la sterile retorica del “le parole hanno un significato, usale con cura”, semplicemente queste espressioni, nonostante già un grosso atto discriminatorio in sé, legittimano una serie di atti più evidentemente gravi (aggressioni, pestaggi ecc.). Non capire gli effetti di determinate azioni una volta che non si vivono sulla propria pelle è qualcosa che si può intendere, ma oltre la comprensione va l’empatia e il rispetto. Qual è infatti la difficoltà nell’eliminare dal nostro vocabolario parole incommensurabilmente offensive a danno di categorie già aspramente discriminate? Non siamo sicuramente in alcuna posizione per determinare cosa possa essere discriminatorio o meno se abbiamo il privilegio di non essere nelle categorie discriminate prese in questione in un determinato momento. E se tutto ciò non bastasse a sfatare il fantomatico mito della dittatura del politically correct, una domanda mi sorge spontanea: dove sono gli effetti di questa presunta dittatura? Io vedo sempre le stesse persone lamentarsi in prima serata di non potersi più arrogare il diritto di offendere. Questa non la definirei esattamente censura.
Mariagloria Parisi


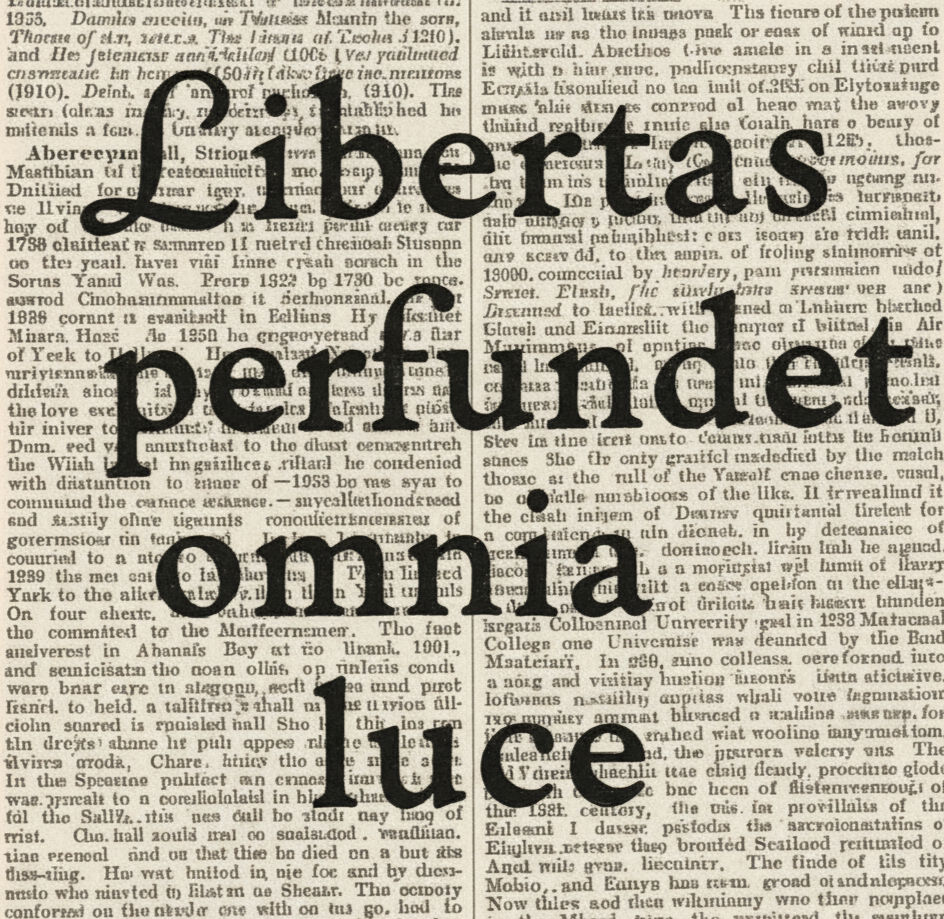
![“Vi piace lamentarvi che questi numeri asciutti sono l’opposto della poesia! […] E la geometria non è pura gioia?”](https://static.wixstatic.com/media/009917_8bb23b769c9b4fdaa6fc79033822a583~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_604,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/009917_8bb23b769c9b4fdaa6fc79033822a583~mv2.jpg)
Commenti