Editoriale: greenwashing
- 7 mar 2023
- Tempo di lettura: 4 min
Viviamo in un mondo green. Dati oggettivi testimoniano che non è ancora stata intrapresa una via che ci assicuri una gestione di successo della questione ambientale, benché l’emergenza dettata dalla crisi climatica sia indiscussa e renda sempre più urgenti azioni che la contrastino. Siamo in perpetuo ritardo rispetto a obiettivi il cui raggiungimento era stato definito improrogabile o persino disposti a mettere in discussione scelte già maturate se le circostanze non sembrano permettere che siano concretate: basti pensare a quei target dell’Agenda 2030 per i quali le stime basate sui progressi registrati finora ci indurrebbero a rassegnarci al fallimento o alla discutibile inclusione di fonti fossili, come il gas naturale, nella tassonomia europea (il sistema che elenca tutte le attività giudicate ecosostenibili dall’UE). Eppure, il cammino verso la sostenibilità non apparirebbe così impervio se ci limitassimo ad ascoltare i messaggi che ci lancia il mercato, dove sempre più prodotti compaiono in una veste eco-friendly, sempre più aziende si impegnano in iniziative che puntano all’impatto zero, sempre più campagne di comunicazione sono improntate alla sostenibilità. Sono queste, infatti, le strategie mediante le quali nel mondo del business, pur di conseguire il successo economico, ci si conforma alle istanze dei consumatori, assicurandosi, al tempo stesso, una reputazione in linea con un ordine di valori “verdi”. Il rischio, tuttavia, è etichettare come etico ciò che non lo è davvero, tanto che per consentire uno sviluppo trasparente della cosiddetta “finanza sostenibile” l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha istituito una task force contro il greenwashing che costituirà uno strumento per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica atto a impedire che nelle tappe della transizione ecologica siano occultate vere e proprie “ecobugie”. È un pericolo che si profila concretamente all’orizzonte, come ha dimostrato, ad esempio, un’inchiesta condotta di recente dal settimanale tedesco Die Zeit, dal quotidiano britannico The Guardian e dall’organizzazione non-profit di giornalismo investigativo SourceMaterial, volta a esaminare se il meccanismo dell’acquisto di crediti di carbonio per la compensazione delle emissioni possa davvero sostenere la lotta al cambiamento climatico. Infatti, se alcune multinazionali vantano considerevoli riduzioni nelle loro emissioni o addirittura una produzione completamente carbon neutral (emissioni zero) è perché mascherano la realtà, la quale talvolta vede persino aggravarsi la loro impronta ecologica, in quanto compensano quest’ultima aderendo a progetti di salvaguardia ambientale. Allo scopo di quantificare l’effettivo vantaggio apportato al Pianeta sono stati istituiti dei crediti che associano ad ogni azione in favore della sostenibilità il numero di tonnellate di CO2 che questa elimina. Potrebbe essere una soluzione ideale, ma determinare tali benefici con accuratezza non è immediato e il fatto che il sistema più sviluppato non sia quello regolamentato dai governi, bensì il mercato volontario, in cui gli enti che rilasciano e certificano i crediti di carbonio adottano criteri propri, offre margini di alterazione dei dati. In particolare, analizzando l’operato dell’organizzazione leader del settore, Verra, è emerso che i modelli utilizzati per quantificare i crediti relativi a progetti per la protezione delle foreste provocherebbero una sopravvalutazione dei loro risultati, al punto tale che al 90% di questi crediti non corrisponderebbe la sottrazione di tonnellate di anidride carbonica dall’ambiente. Per di più, mentre è possibile stimare con esattezza l’impatto di attività legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla piantumazione di alberi, è un calcolo complesso quello volto a definire i pericoli che incombono su una foresta, specie se risulta conveniente per qualcuno escogitare potenziali minacce. Per esempio, per la conservazione di un’area della foresta pluviale peruviana sarebbero stati emessi 80mila crediti di carbonio proprio da Verra perché i proprietari di un piccolo hotel situato lì, trovandosi in difficoltà economiche, avrebbero prospettato come certa la loro decisione di disboscare una zona sufficientemente ampia per trarre dalla vendita del legname ricavato guadagni sufficienti ad evitare la bancarotta, sebbene fossero materialmente impossibilitati a realizzarla: solo mezzi industriali di cui non potevano disporre avrebbero consentito un’operazione del genere nel fitto della giungla. È credibile che Verra certifichi crediti di carbonio in circostanze dubbie come queste in buona fede? O piuttosto bisogna supporre che solo il profitto venga perseguito, in aperto contrasto con quelle che dovrebbero essere le prerogative di un’organizzazione senza scopo di lucro come questa? Al mercato volontario dei crediti di carbonio, nel complesso, va riconosciuto il merito di aver convogliato ingentissimi fondi indirizzandoli, almeno parzialmente, alla tutela dell’ambiente, in una fase in cui soltanto gli investimenti dei privati possono sopperire all’esiguità delle risorse pubbliche; tuttavia, la rete che avrebbe dovuto renderli efficaci ha rivelato delle falle evidenti, nonostante Verra contesti lo studio citato e, dunque, tutte le analisi, tra cui quella ad opera dell’Università di Cambridge, che sono in accordo con quest’ultimo. Unica possibilità per intercettare problematiche come queste è uniformare la regolamentazione del settore secondo canoni condivisi da quanti più organismi possibili, tenendo conto, comunque, della necessità di controlli più approfonditi: anche laddove esistono norme puntuali, il malcostume può sfuggire alle maglie della legge, come ha rivelato un’inchiesta di Report sulla presunta inosservanza del disciplinare sugli allevamenti di polli, soprattutto biologici, da parte del noto gruppo Fileni. In conclusione, ricade sul consumatore la responsabilità di compiere scelte consapevoli in una dimensione che, in verità, non gli fornisce strumenti sicuri per destreggiarsi tra le offerte del mercato. Per vendere, oggi, come suggerisce l’espressione greenwashing, conviene dotarsi di una “riverniciatura verde”, ma per comprare davvero un prodotto sostenibile è indispensabile riconoscervi un’identità che sia tale oltre la superficie.
Paola Carpinteri


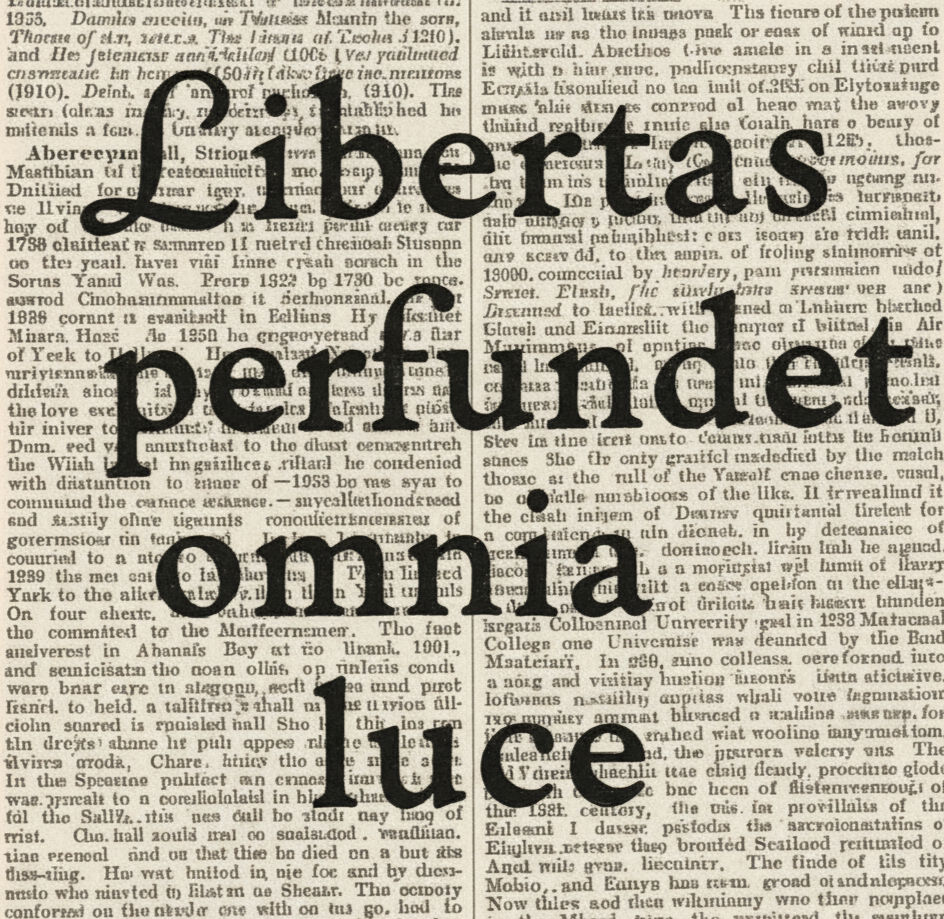
![“Vi piace lamentarvi che questi numeri asciutti sono l’opposto della poesia! […] E la geometria non è pura gioia?”](https://static.wixstatic.com/media/009917_8bb23b769c9b4fdaa6fc79033822a583~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_604,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/009917_8bb23b769c9b4fdaa6fc79033822a583~mv2.jpg)
Commenti